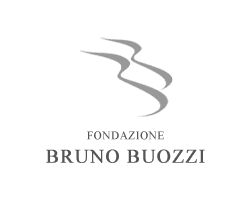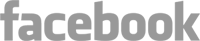Intervento di Antonio Maglie al convegno ’Rileggere Bruno Buozzi a ottanta anni dalla sua morte 1944-2024’
L'italia di ieri, di oggi e di domani.
FONDAZIONE BRUNO BUOZZI

![]()
Fondazione
Bruno Buozzi
Via Sistina, 57
00187 Roma
GoogleMap
C.F. 97290040589
+39.06.6798.547
fbb@fondazionebrunobuozzi.eu
Seguici nella nostra pagina Facebook. Premi MI PIACE e non perderai più nessuna notizia.
Sostienici con il 5X1000
Sostieni la Fondazione Bruno Buozzi con il tuo 5X1000. A te non costa nulla - essendo una quota d'imposta che lo Stato affida alle organizzazione di promozione sociale - ma aiuterai noi a finanziare progetti tesi a favorire gli studi sul sindacalismo promuovendone apposite iniziative.
Come fare? È davvero semplice
- Compila il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico;
- Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale";
- Indica il codice fiscale della fondazione: 97290040589;
- Anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, può destinare il 5x1000.

FONDAZIONE
Bruno Buozzi
L'italia di ieri, di oggi e di domani.
Via Sistina, 57 - 00187 Roma | +39.06.6798.547 | fbb@fondazionebrunobuozzi.eu
Biblioteca
Aperta al pubblico con accesso libero
Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 - il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Museo, Archivio e Collezioni
Aperto al pubblico con accesso libero
Orario Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 - il giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Fondazione
Bruno Buozzi
Via Sistina, 57
00187 Roma
GoogleMap
C.F. 97290040589
+39.06.6798.547
fbb@fondazionebrunobuozzi.eu
Privacy & Cookie Policy
© Fondazione Bruno Buozzi. Tutti i diritti sono riservati.
Credit grippiassociati ICT Design&Development